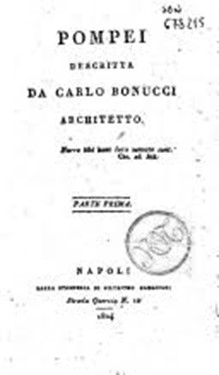Di Carlo Bonucci, architetto nato a Napoli nel 1799, si sa poco, anche tra gli “addetti ai lavori”. E spesso gli tocca di essere confuso con l’omonimo, parente, e più anziano, architetto Antonio Bonucci, il quale fu “Architetto direttore” degli scavi di Pompei dal 1816 al 1819. Di lui, in epoca recente ha scritto l’amico Mario Pagano, archeologo napoletano ed ex allievo della Nunziatella, morto nei giorni scorsi. Questo mio articolo lo devo anche a lui che, con i suoi studi e le sue ricerche su Carlo Bonucci, mi ha aperto la strada della conoscenza.
Del nostro Carlo Bonucci si sa che dopo avere compiuto gli studi nel collegio napoletano degli Scolopi divenne architetto per i suoi studi divulgativi delle antichità pompeiane. Bonucci fu nominato nel 1827 “Architetto Direttore” degli Scavi di Ercolano, dove introdusse la metodologia dello scavo a cielo aperto, non più attraverso pericolosi e “ciechi” cunicoli. Lo scavo sistematico del Teatro ercolanese fu poi per Bonucci, nel 1828, l’occasione per guadagnare sul campo l’incarico di Architetto Direttore anche a Pompei.
Circa dieci anni dopo però, nel 1837, a Pompei fu nominato Architetto Direttore Pietro Bianchi – progettista della Chiesa reale pontificia di San Francesco di Paola, ancora oggi in Piazza del Plebiscito. Con l’avvento di Bianchi, Bonucci conservò il ruolo di architetto, ma solo con funzione “locale”. L’anno dopo, il 1838, vide Carlo Bonucci assumere l’incarico di “Architetto Direttore “degli scavi di Pozzuoli, dove scavò l’Anfiteatro, e assunse la responsabilità di “Sovrintendente ai Restauri delle Antichità di Baia. Infine, dal 1844, Bonucci fu Architetto Direttore del Real Museo Borbonico con estensione dell’incarico ai Reali Scavi di Pompei, Ercolano, Pozzuoli, Capua, Pesto, per la scelta dei “reperti” da trasferire al Real Museo borbonico.
La carriera tumultuosa di Carlo – che lo porta comunque alla carica di Soprintendente alle Antichità di Napoli e del Real Museo – vede il suo pieno riscatto con la riconferma alla guida degli Scavi di Pompei come Architetto Direttore, dopo la rinuncia di Pietro Bianchi. E, da allora, Carlo Bonucci, raccoglie prestigio e riconoscimenti presso numerose Accademie Reali e Istituti internazionali di Cultura. Bonucci non si concede pause, dedicandosi agli scavi di Cuma, mentre dà alle stampe una Pianta Generale degli Scavi di Pompei, che ebbe poi quattro edizioni successive.
Insomma, dal suo denso “curriculum vitae” – che si caratterizza più come un inarrestabile “cursus honorum” – si trae l’immagine di un uomo poliedrico e inquieto, operante in anni altrettanto inquieti di grandi mutamenti politici e storici. La sua colpa fu però l’agire senza la necessaria avvedutezza in certi casi, nel mondo ambiguo dei rivolgimenti politici e in quello statico delle antichità pompeiane, come nel caso in cui fu accusato di avere regalato un paio di vasetti, da poco scavati, a due illustri visitatori provenienti dalla Corte imperiale di Vienna.
E già nel 1847 si verificano i primi dissidi tra Bonucci e l’emergente Giuseppe Fiorelli, nonostante che lo stesso Bonucci lo aveva appoggiato affinché ricevesse l’incarico di Ispettore dei Reali Scavi a Pompei. Ma Fiorelli – per il reato di liberalismo antiborbonico – è imprigionato nell’Aprile 1849 per dieci mesi, mentre Bonucci viene accusato di “illeciti guadagni” da alcuni Impiegati soprastanti degli Scavi di Pompei.
Intanto, la sua divaricazione da Fiorelli si allarga e si consolida negli anni Sessanta, dopo uno scontro con il marchese Spinelli, Principe di San Giorgio, Soprintendente agli Scavi tra il 1850 e il 1863, periodo che vede la scomparsa del Regno delle Due Sicilie e il farsi turbolento e sanguinoso della Unità d’Italia. Altre anonime missive lo accusano di “ladronerie” ut sic e di scarsa vigilanza su alcune spese ordinate per i trasporti di reperti tra Ercolano e Pompei, ove Pietro Bianchi ne avversava l’opera, ricambiato da Bonucci.
Dopo l’arrivo di Garibaldi a Napoli, inaspettatamente, Carlo Bonucci, appoggia la candidatura di Alessandro Dumas a nuovo Direttore del Museo Archeologico di Napoli, poi imposto da Garibaldi. Il fatto fa infuriare Spinelli, che aveva tenuto lontano dagli Scavi di Pompei Carlo Bonucci, dando prima fiducia a Pietro Bianchi e poi credito ai maldicenti contrari a Bonucci. Carlo Bonucci, sorprendendo tutti, accetta la nomina, di “Architetto Giudiziario” presso la Gran corte civile di Napoli e presso i tribunali delle maggiori città campane. L’isola di Capri infine accoglie i suoi ultimi anni di studi estesi fino alle Puglie e, infine, la sua morte, nel 1870.
Ma, prima di chiudere sembra doveroso ricordare la genialità di Carlo Bonucci. Egli è stato soprattutto un grande e meticoloso studioso delle antichità pompeiane, anche prima di diventare Architetto Direttore di Scavi. Ma la sua opera straordinaria è rimasta misconosciuta per i suoi non buoni rapporti con il “Nume tutelare” dell’Archeologia postunitaria, Giuseppe Fiorelli. Questi, napoletano di nascita, di famiglia pugliese, aperta al liberalismo antiborbonico allora nascente alimentato dalla Corona Inglese, che già progettava caduta del Regno napoletano. Ecco il primo elemento che costituì sempre un ostacolo all’amicizia e, in certe fasi, alla collaborazione tra i due eminenti antichisti, i quali avevano soltanto un tratto comune: entrambi non erano archeologi, essendo Bonucci architetto e Fiorelli numismatico. L’altro elemento di sostanziale diversità, a parte il sentire politico, fu l’età, in quanto Fiorelli era molto più giovane di Carlo Bonucci, dal quale lo divideva una differenza quasi un quarto di secolo. Essi rappresentavano quindi due mondi diversi, fatalmente.
E’ fatto certo però che il vero inventore dei “calchi” in gesso non fu Giuseppe Fiorelli, che iniziò a farli realizzare soltanto nel 1865, ma piuttosto Carlo Bonucci, che cominciò a realizzarli già negli anni Venti dell’Ottocento, circa quaranta anni prima. Il “liberale” Fiorelli, però, fece eseguirei calchi delle persone vittime dell’eruzione, mentre Bonucci, ex alunno degli Scolopi e cattolico osservante, si era limitato a eseguire calchi di Porte in legno e, comunque, di oggetti inanimati.
La genialità di Carlo Bonucci non si fermò ai calchi, ma si si rivelò tale anche nella sua Guida “Pompei Descritta”, quando – nella Nota n° 12 dell’ampio corredo di Note che chiudono la Guida – egli scrive così: “Dall’essersi osservato nell’interno dell’acquidoto che passa pel Tempio d’Iside le tracce dell’opera reticolata, sembra evidente, che la più gran parte del Canale del Conte, appartenga all’antico acquidotto di Pompei, nel quale dovette incontrarsi.”
Il suo riferimento esplicito alla evidente epoca arcaica del Canale Sarno è un urlo di verità, affidato alla sua dotta prosa.
(continua)