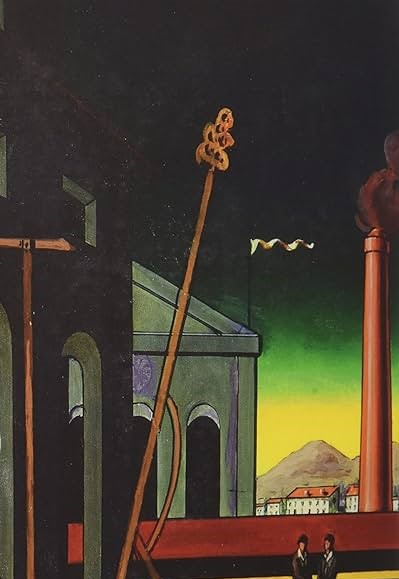Nel quarto libro del “Mondo come volontà e rappresentazione” (qui nella traduzione di Gian Carlo Giani), dopo che nei capitoli 61 e seguenti “si esalta il diritto contro l’ingiustizia e a compensazione della ‘eris’, o contesa, tra gli uomini” , nel capitolo 67 si indaga sulla pietà, notando come “in italiano, compassione e puro amore vengono indicati con la stessa parola: pietà”. Ma alcuni interpreti preferiscono distinguere: compassione, come partecipazione al dolore d’altri; pietà, come atteggiamento di devozione verso alcuni.
«Noi abbiamo visto, come… nasca in un grado minore la giustizia e in un grado maggiore la vera e propria bontà d’animo, che si è mostrata come amore puro, cioè disinteressato, per gli altri. Quando questo, poi, diventa perfetto, mette completamente sullo stesso piano l’individualità altrui ed il suo destino con il proprio: più avanti esso non può andare, non essendovi ragione di preferire l’individualità altrui alla propria.
(…) Devo ricordare che prima abbiamo trovato come alla vita nel suo complesso la sofferenza sia essenziale, ed inseparabile da essa; e che abbiamo visto come ogni desiderio abbia origine da un bisogno, da una mancanza, da una sofferenza, e che perciò ogni appagamento è soltanto un dolore eliminato, non una felicità positiva apportata; che le gioie mentiscono al desiderio, affermando di essere un bene positivo, mentre in verità hanno una natura soltanto negativa e non sono altro che la fine di un male (…).
Ogni amore vero e puro è compassione, ed ogni amore che non è compassione, è egoismo. L’egoismo è l’eros, la compassione è l’agape. Spesso entrambi si trovano confusi. Perfino la vera amicizia è sempre una mescolanza di egoismo e di compassione: il primo si ha nel compiacersi della presenza dell’amico, la cui individualità corrisponde alla nostra, e costituisce quasi sempre la maggior parte dell’amicizia; la compassione si mostra nella sincera partecipazione al suo benessere e al suo dolore ed ai sacrifici disinteressati che si fanno per lui… A conferma del nostro principio paradossale si può osservare che il tono e le parole della lingua e delle carezze dell’amore puro coincidono pienamente con il tono della compassione; si può anche osservare, per inciso, che in italiano compassione e amore puro sono designati con la stessa parola: pietà.
Qui è anche il luogo per spiegare una delle peculiarità più evidenti della natura umana, il PIANTO, che, come il riso, appartiene alle espressioni, che distinguono l’uomo dall’animale. Il pianto non è affatto espressione assoluta del dolore, dal momento che si piange per dolori minimi. A mio avviso, non si piange addirittura mai direttamente per il dolore sofferto, ma sempre soltanto per il suo ripetersi nella riflessione (…). Del tutto conforme alla spiegazione fornita è la descrizione che Petrarca fa dell’origine delle sue lacrime, esprimendo il suo sentimento con semplicità e verità:
I’ vo pensando, et nel penser m’assale
una pietà sì forte di me stesso,
che mi conduce spesso
ad altro lagrimar ch’i’ non soleva.
Non è la propria perdita, ciò che un dolente piange: ci si vergognerebbe di simili lacrime egoistiche…, lo coglie la compassione per la sorte di tutta l’umanità, che è vittima della finitezza, in conseguenza alla quale ogni vita così solerte, spesso così ricca di attività, deve spegnersi e finire nel nulla.»
Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione.