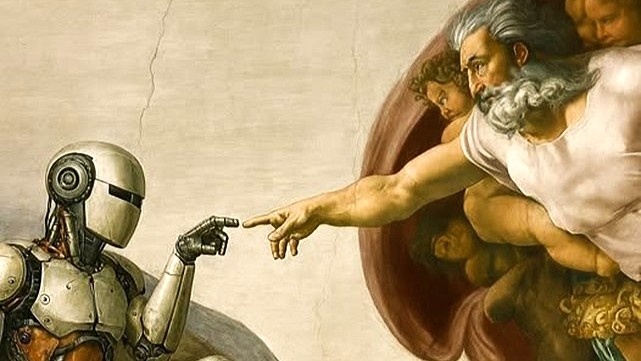Piero Barducci, Una volta c’era l’uomo, (2025)
E’ uscito oggi il numero 8 di Lab Politiche e Culture (http://www.labpolitiche.it), il trimestrale online del quale Gente e Territorio è partner, sul quale è apparso l’editoriale che vi proponiamo. Del che ringraziamo Lab e l’Autrice, Titti Marrone.
Una volta si chiamava “questione meridionale” e dava la stura ad accaniti dibattiti con spargimento di sangue da cui si usciva anche stremati ma ciascuno rigorosamente sulla propria posizione di partenza. Da quando la QM è uscita del tutto dalla sfera pubblica insieme alla connessa categoria dei meridionalisti, appaiono infiacchite anche le voci degli “intellettuali”, perfino nella declinazione di “società civile”: questa si appalesa sempre più raramente su giornali e riviste – che peraltro si leggono pochissimo – e alimenta tra i più cospicui contingenti di astenuti alle votazioni politiche. Così viene ormai chiamata in causa di rado, sorte condivisa con gli intellettuali, meridionali e no, che appaiono completamente evaporati, almeno nella tipologia di qualche decennio fa. Eppure, per sommo paradosso, se non nel discorso pubblico, in campo culturale e artistico la centralità simbolica e creativa delle metropoli meridionali non è mai stata evidente e celebrata come oggi.
Prendiamo Napoli: forse mai come oggi l’immaginario nazionale ne è tanto pervaso, affascinato dalle sue rappresentazioni letterarie, filmiche, musicali, perfino calcistiche. Il New York Times connota la città come “brilliant” almeno da quando “L’amica geniale”, libro e fiction, ha messo ai margini il maledettismo veicolato da “Gomorra”. E mai tanti scrittori, musicisti, operatori, cineasti rigorosamente napoletani hanno affollato la scena nazionale come avviene oggi. Intellettuali, certo, ma di fisionomia del tutto diversa da quelli di un tempo. Più produttori diretti di rappresentazioni sulla e della città che chiosatori da rivista in politichese, più artigiani dell’esser napoletani che suoi commentatori. Un esempio efficace di “fabbricanti” d’immagini viene dalla schiera di filmaker, registi, sceneggiatori, operatori filmici a vario titolo che, come sottolinea il produttore Luciano Stella, stanno facendo di Napoli il secondo polo dell’audiovisivo nazionale dopo Roma. Per giunta, la città che raccontano in serie tv, animazioni, documentari e fiction, così come quella descritta dai tanti scrittori napoletani sembra aver superato la configurazione bifronte delle “due città”, la lazzarona e l’aristocratica descritta da Mimì Rea. Così come quella borghese di Raffaele La Capria e l’altra inquieta di Annamaria Ortese. Raccontando un luogo anche più affascinante e complesso.
E a proposito di paradossi, e di intellettuali: a Napoli è capitato spesso di aver vissuto impennate di creatività artistica in coincidenza con periodi assolutamente bui della sua storia. A ridosso del colera del 1884, la città conobbe una sorta di Belle époque culturale con un dibattito vivacissimo che avrebbe sollecitato l’inchiesta Saredo e promosso la prima legge speciale con la costituzione dell’Ilva. Fu attraversata da un fervore d’iniziative musicali, teatrali, figurative, letterarie che la proiettarono sulla ribalta internazionale da protagonista delle prime forme di produzione culturale di massa. Un esempio per tutti, il mondo della canzone, dove le feste di Piedigrotta avviarono un’autentica industria musicale moderna, con la nascita di brani apprezzatissimi in ogni ceto sociale cittadino e esportati anche all’estero. Per dire: Era de maggio, versi di Salvatore Di Giacomo, musica di Mario Costa, fu composta per l’affollatissima Piedigrotta del 1885, l’anno successivo al colera.
E oggi? Stando ai dati statistici, e a operazioni mediatiche come la classifica annuale sulla vivibilità nelle città italiane del Sole 24 Ore, quello di oggi sarebbe un momento totalmente negativo per la città. Anni fa, contro il metodo-classifiche protestarono molti intellettuali del Sud e a rappresentarli tutti si levò la voce di Erri De Luca: “Considero qualità della vita la cortesia e il sorriso entrando in un negozio. La musica per strada. L’ironia diffusa che permette di accogliere queste graduatorie con “ma faciteme ‘o piacere”.
Per il 2025, la classifica del Sole attesta un peggioramento netto rispetto al passato: sistema Napoli al posto 104 (su 107) e Bergamo al primo. E nessun intellettuale si fa vivo per contestarla. Intanto Il Mattino, principale quotidiano cittadino, cerca di avallare l’idea di un cambio di paradigma con un modello di città che vede stuoli di turisti da ogni parte del mondo invadere i Decumani, alloggiare in improbabili B&B ricavati dai bassi, addentare pizze alla Sanità, il quartiere riscoperto.
Ma dove si ferma davvero il pendolo sempre in bilico tra città degli angeli e dei diavoli? E anche, a Napoli fa bene rinunciare a intellettuali senza più seguito, a parte gli esponenti di un ceto medio riflessivo tutt’al più capaci di animare comitati anti-movida? Impossibile rispondere se non si collega il fenomeno dell’evaporazione degli intellettuali all’altro, della crisi di quella politica di cui sono sempre stati più o meno espressione. In “Nostalgia di domani” (Il Mulino, pagg. 218, euro 15) qualche anno fa lo storico Paolo Macry mise ben in luce il rapporto tra intellettuali napoletani e politica, e insieme il dominio delle figure carismatiche nella storia cittadina, da Masaniello a Lauro a Valenzi a Bassolino, De Magistris e De Luca, collegabili a una vecchia e mai superata vocazione monarchica della città. Figure che, a riguardarle oggi, appaiono accomunate da tratti da capipopolo impossibilitati ad apparire “normali”, a volte addirittura macchiettistiche.
Nel sentire popolare, e nel tributo al carisma, a sostituirle oggi appaiono altre immagini. Non quella dell’attuale sindaco, un signore pacato dal fare sommesso (verrebbe da dire: finalmente) né la visione di un vero progetto per la città, purtroppo latitante in ogni campo, figurarsi quello culturale. In sostituzione, si insediano l’attesa un po’ miracolistica dell’ultima tranche di fondi del PNRR e la preparazione dell’America’s Cup. Intanto gli “esclusi”, quelli che non si sentono presi in considerazione, producono da sé visioni simboliche, per esempio nella musica: prima i neomelodici, ora i rapper, espressione di fasce deboli che, se non si sentono rappresentate, si sanno rappresentare da sole. E si fa conto su altre robuste visioni, a cominciare da quella sempiterna di San Gennaro, o della squadra del Napoli, cui un quarantennio di anni fa un nucleo di intellettuali dedicò un memorabile Te Diegum, coniugando passione popolare e devozione laica. Fu l’esempio di una felice sintesi oggi impensabile. Ma allora c’erano la politica e le ideologie, c’erano gli intellettuali e c’era Maradona, ed era tutta n’ata storia.