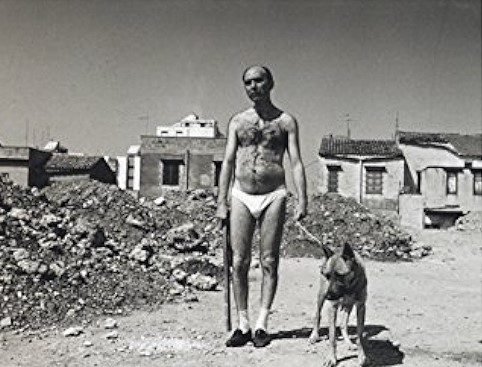L’intera esistenza di Goffredo Fofi è stata segnata dalla sua passione per il cinema. Il prodotto-film, gli autori più significativi, i suoi divi. Proponendone una lettura che ne facesse emergere il suo intreccio con le dinamiche e le trasformazioni sociali ed economiche. Antropologiche, in alcuni casi. Alla critica cinematografica e alla sua politicità ha dedicato riviste oramai ‘storiche’ come ‘Ombre rosse’ e una lunga serie di monografie e di libri. Fino a questo del 2015, ‘Il cinema del no. Visioni anarchiche della vita e della società’, in cui Fofi propone all’attenzione a “quel cinema che ha cercato l’oltre e il fondo, che ha esplorato territori e linguaggi capaci di mettere a nudo ogni maschera del potere, ogni cultura dell’accettazione, ogni mercato dell’intelligenza e dell’immaginazione. Tanti gli esempi di questo rapporto diretto o indiretto tra cinema e anarchia che possono essere rintracciati in film e registi sia del passato, a partire da maestri come Vigo e Bunuel, sia del presente, in autori come Kaurismàki, Oshima o Cipri e Maresco”.
«Grande è la confusione nel campo della ribellione – peraltro così scarsa e così fragile – allo stato delle cose presenti e alle sue evidenti e micidiali ingiustizie, e la parola “anarchia” non basta a fare chiarezza, e a proporre qualcosa che vada oltre alla coscienza e alla dichiarazione che “questo mondo, così com’è, proprio non mi piace”, e a proporre un modo di agire, di comportarsi, di rapportarsi al prossimo, e a proporre un sì, non soltanto a gridare un no. È per questo che la definizione di anarchia che mi pare più consona ai nostri tempi è quella che ci dette un pomeriggio di qualche anno fa, in un incontro con pochi giovani che sapevano chi era e ammiravano i suoi scritti, Colin Ward, il mite e saldo Colin autore della più bella sintesi recente su L’anarchia. Un approccio essenziale. Gli chiedemmo: cos’è in primo luogo e in definitiva, per te e proprio per te, l’anarchia? La sua risposta ci sconcertò e mi entusiasmò, e ancora mi entusiasma: “una forma di disperazione creativa”.
Fu proprio l’accento sulla disperazione, bensì creativa, a convincerci. Una definizione esperienziale lontana da ogni trionfalismo e da ogni banale ribellismo giovanile (con o senza causa). Anche se non mi pare che egli l’abbia spesso usata, indicava assai bene il suo stato d’animo. Oggi più che mai, di fronte al disastro del mondo, della democrazia e della politica, di fronte alla sottomissione degli uomini al potere di pochissimi e ai nuovi e tremendi modi di manipolare le coscienze e alle nuove barbarie di chi vorrebbe imporre un’altra idea, meno subdola ma non meno tremenda, della società e dell’uomo, è ancora possibile essere ottimisti, credere nella vittoria del bene (del “vero” e del “giusto” e del “bello”), fidare in un mondo migliore, se non per noi almeno per i nostri figli? The horror, gridava Kurtz alla fine del Cuore di tenebra, ma anche questa parola ha perduto la sua forza originaria, ed è diventata un genere cinematografico e letterario di consumo, una provvisoria e stantia eccitazione dei sensi per persone che hanno bisogno di risvegliarli, e non trovano di meglio che il buio la paura la morte. È da decenni che la parola “conflitto” è scomparsa dal vocabolario, demonizzata come male assoluto e come non fosse invece il sale di ogni democrazia e di ogni difesa dei deboli verso i forti. È accaduto dopo la sconfitta secca dei movimenti e delle rivoluzioni, con una nuova economia che, per un trentennio, ha illuso di un benessere crescente per tutti (…), con l’addormentamento progressivo delle coscienze negli anni della maggior pace sociale e del maggior conformismo visti nella nostra storia dall’Unità in avanti, con il suicidio della sinistra (e la constatazione che ne consegue che il pci è stato uno degli inganni maggiori vissuti dal paese), e con l’acquisita e pressoché assoluta complicità degli intellettuali al sistema di potere determinato dai padroni e maestri della finanza e dell’economia.»
Goffredo Fofi, Il cinema del no. Visioni anarchiche della vita e della società.