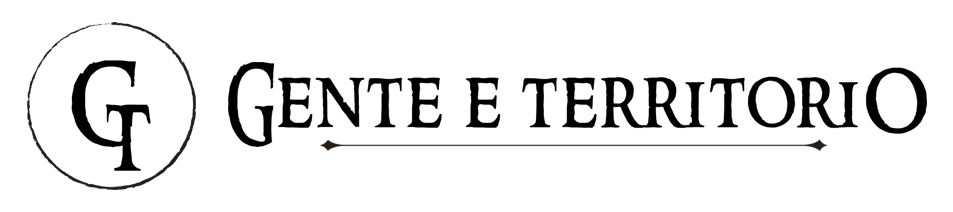L’autore, giornalista professionista, è guida volontaria presso il Museo della mente nel comprensorio dell’ex manicomio S. Maria della Pietà di Roma e collabora con Medici del Mondo-Italia. Ha scritto diversi saggi su temi di carattere sociale per quotidiani e riviste e si è sempre occupato di questioni legate alla sanità nazionale e internazionale. Per Ediesse ha pubblicato “Il bambino con le braccia larghe” (2010) e “Gli amortali” (2015); per Feltrinelli ha scritto insieme a Vittorio Agnoletto “Aids: lo scandalo del vaccino italiano” (2012).
Pochi altri argomenti si prestano a un florilegio di luoghi comuni come la pazzia e le sue manifestazioni di cui, a intervalli più o meno regolari, si occupa la cronaca dei giornali e delle televisioni, scatenando la fantasia morbosa dei social network. Se n’è avuta ampia testimonianza dopo i recenti omicidi di Ardea ad opera di un “folle”, di uno “squilibrato” come si è letto (tanto per non rinunciare allo stigma), che ha riaperto ancora una volta un feroce dibattitto fra detrattori e sostenitori della legge 180. Parliamo della famosa legge Basaglia che avrebbe rimesso in libertà i pazzi. I quali una volta erano rinchiusi nei manicomi per la sicurezza e la tranquillità di tutti, ma soprattutto per la rimozione dalla consapevolezza comune della pazzia e delle sue manifestazioni.
Nulla di più fuorviante di un dibattito che non sfiora neppure i dati reali della questione, che invece andrebbe affrontata senza paraocchi ideologici e soprattutto senza ricorso ai più vieti luoghi comuni.
Dunque: la legge Basaglia. Si può dire che, come nel caso del cristianesimo e del marxismo che avrebbero smarrito la purezza iniziale nella loro applicazione concreta, conteneva anch’essa i germi delle successive deviazioni, anche se qui non parliamo di dottrina ma di disposizioni di legge? È pur vero che alcuni dei sostenitori della chiusura dei manicomi estesero i sacrosanti principi su cui si fondava la legge 180 – in sintesi l’approccio al disagio mentale in termini curativi e non più esclusivamente contenitivi (e punitivi) – al punto di ridurre il concetto di malattia mentale a una categoria sociologica: non più patologia del singolo ma patologia di una società intera che genera disagio mentale. L’effetto di questo approccio ideologico, che spinse alcuni teorici a negare l’esistenza stessa della malattia mentale come manifestazione morbosa di una tara individuale (di origine organica, di origine ambientale? Non addentriamoci su un terreno che porterebbe lontano, forse da nessuna parte), è stato quello di sottovalutare enormemente la sofferenza delle persone e dei loro familiari.
Per fortuna questa deviazione, comparsa nel corso dei super-ideologizzati anni 70 in cui fu varata la legge 180, ha perduto forza col passare degli anni. Ed è stata invece la legge – assieme ad altri fattori che vedremo sinteticamente, a cominciare dal quasi contemporaneo varo del Servizio sanitario nazionale (1978) – a far compiere un enorme balzo in avanti alla psichiatria, alla cura del disagio mentale e all’approccio nei confronti della follia. Uno dei suoi principali meriti è stato quello di differenziare gli interventi a seconda delle diverse patologie. Non tutti rinchiusi in un luogo contenitivo e promiscuo, ma diversi tipi di approccio per i diversi casi che si manifestano. Il tutto sotto la gestione e il coordinamento dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali: comunità di recupero per chi ha qualche chance di tornare a una vita “normale” (il cosiddetto “recovery”); casa famiglia per chi riesce a convivere con il proprio disagio; ritorno alla famiglia di origine se compatibile e ben accetto; centri di igiene mentale in day hospital per eventuali ricadute o necessità di cure continue; Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per casi di cronicità difficili da gestire altrove; infine i pronto soccorso psichiatrici per i casi di emergenza. Parliamo in questo caso dei Sevizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) ai quali si accede volontariamente, oppure tramite chiamata del 118. Il che comporta un sopralluogo di uno staff medico e infermieristico nelle abitazioni private da cui proviene la chiamata, con la presenza di uno psichiatra che stabilisce la gravità del caso, la necessità di un ricovero e l’eventuale Trattamento sanitario obbligatorio (TSO).
Quello appena descritto sarebbe il migliore dei mondi possibili. In realtà i servizi in questione si sono rivelati largamente insufficienti, spesso inefficienti ed estremamente squilibrati dal punto di vista territoriale, con grandi differenze tra le regioni e persino nell’ambito di una stessa regione. Inoltre la loro istituzione è andata di pari passo con la progressiva privatizzazione dei servizi e l’indebolimento delle risorse messe a disposizione del pubblico, in particolare per la psichiatria. Per limitarsi a un solo esempio le RSA, oltre a essere i luoghi in cui generalmente sono ricoverati gli anziani, sono posti letto che le cliniche private convenzionate riservano a pazienti psichiatrici in cura presso il Servizio sanitario nazionale. Solo che tali posti letto – con le debite eccezioni ovviamente – sono confinati nei sottoscala e nei luoghi meno visibili delle cliniche, spesso rinchiusi con chiavistelli a doppio mandato e affidati a un personale largamente insufficiente e impreparato. Per non parlare degli SPDC, nascosti nei luoghi meno accessibili degli ospedali, spesso fatiscenti, e con un palese sottodimensionamento di medici, infermieri e operatori di sostegno, in particolare psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali. Una realtà resa sempre più drammatica dal vero e proprio boom del disagio psichico dopo l’inizio della pandemia Covid-19 tra i giovani (+20 per cento di suicidi giovanili durante il periodo del lockdown) e tra la popolazione degli immigrati che, in percentuale commisurata alla loro presenza nel nostro paese e alle traversie che li hanno condotti in Italia, occupano una quota considerevole dei posti letto negli SPDC, spesso trascorrendo intere giornate senza rivolgere parola ad alcuno che ne capisca la lingua e le necessità.
Se mai qualcuno invocasse il ricorso ai metodi di una volta, sappia che nella maggior parte degli SPDC si fa ancora uso di letti e fasce di contenzione. Per non parlare dell’elettroshock, per fortuna limitato ad alcune cliniche specializzate e sotto stretto controllo medico. Anche se oggi viene utilizzato solo in casi molto circostanziati, in anestesia totale e non più indiscriminatamente e da svegli come avveniva in passato, non è stata detta una parola definitiva sulla sua utilità terapeutica e sugli effetti collaterali, così come è avvenuto con gli psicofarmaci. Alcuni dei quali, peraltro, agiscono da elettroshock chimici e quindi sostituiscono egregiamente quel marchingegno infernale. Questo non deve assolutamente sminuire il ruolo degli psicofarmaci, che costituiscono la vera rivoluzione nell’approccio al disagio mentale, anche se talora se ne fa un uso smodato e incontrollato per il quieto vivere dei medici e degli infermieri.
Quindi si tranquillizzino i sostenitori del ritorno ai manicomi. I manicomi esistono, anche se camuffati all’interno di strutture pubbliche o private, magari in luoghi più decentrati rispetto ai vecchi complessi monumentali per dare meno nell’occhio. Coloro che sfuggono ai TSO o si trovano, magari temporaneamente, fuori controllo medico, come nel caso dell’omicida di Ardea, costituiscono una minoranza assolutamente irrilevante dal punto di vista statistico. E la loro esplosione di follia, magari amplificata dal caldo o da altri fattori – sarebbero da tenere d’occhio ad esempio i weekend e i periodi prossimi alle vacanze in cui le città si svuotano – rientra nel novero dei casi difficili da prevedere e da monitorare. Come l’uomo che morde il cane, tanto per rimanere nel campo dei luoghi comuni.
D’altra parte è sbagliato avere anche su questi temi un approccio ideologico. Una cosa sono le teorie sull’umanizzazione, i diritti umani e civili, i trattamenti che rispettano la dignità dei malati, “imparare a convivere con il proprio disagio”, e così via: tutte belle parole che in certi casi lasciano il tempo che trovano. Altra cosa è avere a che fare con pazienti che non rispondono a nessun tipo di cura. E, soprattutto, un’altra cosa è vivere nella trincea degli SPDC e nei pronto soccorso degli ospedali dove, in assenza di un filtro adeguato, arrivano pazienti di tutti i tipi: da quelli in stato di agitazione psico-motoria ai depressi, dai senza casa ai criminali in preda a furia devastatrice, dai turisti in crisi mistica agli aspiranti suicidi.
Invece di adeguarsi ai nuovi bisogni, questi reparti ospedalieri vedono diminuire progressivamente le risorse umane ed economiche a loro disposizione, per effetto di tagli alla Sanità, periodiche spending review, razionalizzazioni e tagli lineari, blocchi del turn over o qualsiasi altra decisione assunta dalle direzioni ospedaliere, pronte a sacrificare in primo luogo – sembra quasi un destino ineluttabile – i reparti più ingovernabili e onerosi dal punto di vista economico. Uno degli effetti più macroscopici è la condizione di stress alla quale sono sottoposti medici e infermieri, che vivono in continuo stato di emergenza e senza turni di riposo adeguati, i medici costretti a dividersi tra reparto e pronto soccorso, gli infermieri che sono i più esposti al rischio “burn-out” (altro termine inglese molto di moda che significa logorio, esaurimento) per il loro contatto quotidiano e prolungato con la follia. (1)
Il 24 gennaio 2013 la Conferenza Stato Regioni fissò nel 5% del Fondo Sanitario Nazionale la spesa da destinare al settore della Salute Mentale. Solo tre aree – le Provincie autonome di Trento e Bolzano e l’Emilia-Romagna – sono riuscite a raggiungere o superare quell’obiettivo (6,3% nella provincia autonoma di Trento contro il 2,2% della Basilicata che figura all’ultimo posto), mentre più della metà delle Regioni si attestano ben al di sotto della media nazionale. Media che attualmente risulta pari al 3,5%, a fronte di cifre comprese fra il 10 e il 15% di altri grandi paesi europei (Francia, il Regno Unito, Germania). (2)
In questa situazione, obiettivi come la prevenzione diventano un vero e proprio miraggio, mentre appare sempre più gravoso lo sforzo di diversificare e ampliare i protocolli di trattamento innovativi basati sulle evidenze, come richiederebbe la sempre maggiore complessità dei casi da trattare, siano essi di tipo psicosociale (“dagli interventi psicoeducativi a quelli di rimedio cognitivo, dalle terapie cognitivo comportamentali ai programmi supportati di reinserimento lavorativo per i pazienti affetti da patologie gravi”, secondo la denuncia degli autori nell’articolo citato in quotidianosanità.it) o di tipo farmacologico. Tutto ciò sta portando a provvedimenti come l’esclusione dai prontuari terapeutici di alcuni farmaci di nuova generazione nel settore degli antidepressivi e degli antipsicotici, all’imposizione ai dirigenti di Dipartimento e di struttura di tagli degli ordini relativi agli stessi farmaci, cioè quelli più innovativi e a lunga durata d’azione. Tali provvedimenti comportano il ritorno ai trattamenti con farmaci di prima generazione o con farmaci per via orale. Secondo gli esperti, i primi presentano rilevanti problemi di tollerabilità rispetto ai nuovi, mentre i secondi espongono a maggiori rischi di ricaduta, generando un aumento dei costi per ricoveri ospedalieri e per inserimenti residenziali.
(1) Scrivono a questo proposito Bernardo Carpiniello, Claudio Mencacci ed Enrico Zanalda, rispettivamente Presidente nazionale, ex Presidente e Segretario nazionale della Società italiana di psichiatria (articolo pubblicato il 22 dicembre 2017 su quotidianosanità.it con il titolo “Salute mentale. Dimenticata dallo Stato, ma nuove malattie e incombenze rischiano di far saltare il sistema”): “L’Italia ha costruito negli ultimi quarant’anni un capillare sistema pubblico, fondato su una rete diffusa costituita da oltre 900 Dipartimenti di Salute Mentale, alla quale viene affidato complessivamente il compito della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali e più in generale del disagio psichico. Questo sistema, giustamente ritenuto a livello internazionale un modello di riferimento, in quanto concreta realizzazione della ‘psichiatria di comunità’, corre un ‘doppio rischio’: da un lato quello del suo smantellamento progressivo all’interno del silenzioso processo di accorpamenti che sta avvenendo in Italia a seguito della creazione di Aziende sanitarie sempre più ampie. Dall’altro quello di non riuscire a superare nemmeno le difficoltà quotidiane causate dall’aumento esponenziale di alcuni tipi di patologie mentali, con un altissimo tasso di crescita, come i disturbi dell’umore e d’ansia (che oggi da soli rappresentano più un terzo dell’utenza), le ‘nuove patologie’ (disturbi di personalità, ‘dipendenze comportamentali’, disturbi mentali dovuti a uso di sostanze), le nuove incombenze (assistenza psichiatrica nelle carceri, cura dei pazienti autori di reato, tutela della salute mentale dei migranti) e la persistenza di uno zoccolo duro di persone affette da disturbi mentali gravi di tipo psicotico, che da solo assorbe oltre il 60 per cento delle risorse”. “Le crepe del sistema pubblico – concludono gli autori – sono amplificate dal progressivo impoverimento delle risorse di personale (in molte regioni italiane gli organici sono addirittura la metà di quelli fissati sulla base dell’ultimo Progetto Obiettivo Nazionale) e dalla generale scarsità di risorse finanziarie”.
(2) La salute mentale in Italia. Analisi delle strutture e delle attività dei Dipartimenti di Salute Mentale, a cura di F. Starace, F. Baccari, F. Mungai.