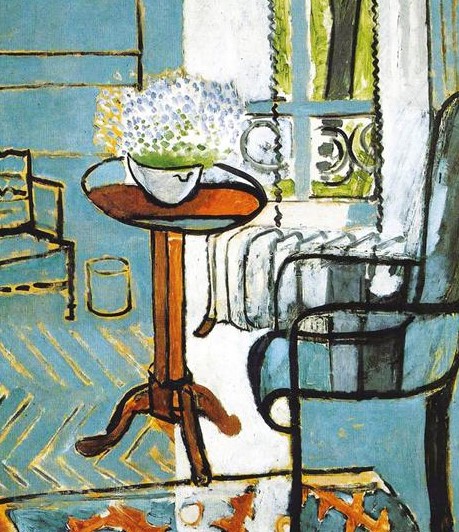Questa ‘novella inedita’ di Marcel Proust è inserita nella raccolta ‘Il corrispondente misterioso’ per le ‘Éditions de Fallois’ nel 2019: “Bernard de Fallois aveva formalmente espresso il proposito di mettere a disposizione degli studiosi l’intero archivio raccolto nel quadro delle sue ricerche sulla genesi di ‘Alla ricerca del tempo perduto’. In particolare, desiderava evitare che alla sua morte fosse disperso in un’asta, e far conoscere in modo più completo l’opera di Proust. La presente pubblicazione risponde dunque alla sua più intima volontà”. Si tratta di testi manoscritti, allo stato di abbozzi, che precedono di molti anni la sezione ‘Un amore di Swann’ del primo volume di ‘Alla ricerca del tempo perduto’, ‘Dalla parte di Swann’. “Questo testo di due pagine si fonda sul gioco dell’enigma: crediamo di leggere un monologo amoroso finché le ultimissime parole non rettificano il significato complessivo. Sembra che Proust sia già entrato in contatto con la teoria di Schopenhauer… secondo la quale chi ascolta un pezzo, posto dalla musica, a titolo eccezionale, di fronte alla voce della Volontà, applica su quella voce le Rappresentazioni che gli fornisce la sua fantasia, e istintivamente mette così in relazione melodia e immagini, senza che nulla giustifichi tale rapporto” (Luc Fraisse, accademico di Strasburgo e curatore della raccolta).
«Ma ben presto la mente intuisce che quelle promesse deliziose, l’essere che le ha fatte non fu mai in grado di mantenerle e combatte con impazienza contro la parete che la reprime; così l’aria che come la mente aspira sempre a riempire più vasti spazi, si è precipitata non appena le si è aperta un’estensione più vasta, e di nuovo è stata compressa. Una sera mi sono fatto ingannare dai vostri occhi, dalla vostra andatura, dalla vostra voce. Ma ora so esattamente fin dove arriva tutto ciò, quanto sia vicino il limite, e il momento in cui non dite più nulla, lasciando scintillare di più nel vago i vostri occhi, per un istante come una luce che non è possibile mantenere a lungo a quel grado di splendore. E so anche caro poeta fin dove arrivi la vostra gentilezza per me e da dove venga, e anche la legge della vostra originalità che una volta scoperta consente di prevederne le regolari sorprese e di esaurirne l’apparente infinitezza. Tutta la grazia che potete dispensare è lì, incapace di aumentare con il mio desiderio, di variare secondo il mio capriccio, di unirsi al mio essere, di obbedire al mio cuore, di guidare la mia mente. Posso toccarla e non posso spostarla. È un cippo stradale. L’avevo appena raggiunto e già l’ho superato. Vi è però un regno di questo mondo dove Dio ha voluto che la Grazia mantenesse le promesse che ci faceva, discendesse fino a giocare con il nostro sogno, e lo elevasse fino a guidarlo, assumendo la sua forma e dandogli la sua gioia, mutevole e non inafferrabile, ma piuttosto resa sempre più grande e varia proprio dal possesso, regno dove uno sguardo del nostro desiderio ci restituisce subito un sorriso della bellezza, che nel nostro cuore si tramuta in affetto e che essa ci restituisce in infinito, dove si assapora senza movimento la vertigine della velocità, senza stanchezza lo sfinimento della lotta, senza rischio l’ebbrezza di scivolare, balzare, volare, dove a ogni minuto la forza si commisura al volere, e al desiderio la voluttà, dove tutte le cose accorrono a ogni istante per assecondare la nostra fantasia e la appagano senza stancarla, dove non appena [è] avvertito un incanto, mille incanti vi si uniscono, che pur diversi convergono, che catturano nella nostra anima [sic], in una rete a ogni istante più stretta, più vasta e più dolce: è il regno della musica.
[A questa parabola potrebbero riallacciarsi due pagine manoscritte separate. La dottrina della musica di Schopenhauer è qui orientata verso una compensazione dell’incomunicabilità fra le anime.]
Talvolta una donna o un uomo ci lascia intravedere, come una finestra buia che si illuminasse vagamente, la grazia, il coraggio, la dedizione, la speranza, la tristezza. Ma la vita umana è troppo complessa, troppo seria, troppo piena di sé e come troppo sovraccarica, il corpo umano con le sue molteplici espressioni e la storia universale che esso porta iscritta, ci fa pensare a troppe cose perché una donna sia mai per noi. La grazia senza accessori, il coraggio senza freni, la dedizione senza riserve, la speranza senza limiti, la tristezza senza scorie. Per assaporare la contemplazione di quelle realtà invisibili che sono il sogno della nostra vita, e perché non abbiamo soltanto di fronte donne e uomini, il brivido del loro presentimento, ci vorrebbero anime pure, spiriti invisibili, geni che hanno la rapidità di volo senza la materialità delle ali capaci di offrirci lo spettacolo dei loro sospiri, del loro slancio o della loro grazia, senza incarnarlo in un corpo. Poiché se anche il nostro corpo potesse goderne, bisognerebbe che il gioco dei suoi spiriti si incarnasse, ma in un corpo sottile, senza dimensione e senza colori, al tempo stesso lontanissimo e vicinissimo a noi, che ci desse nel più profondo di noi stessi la sensazione della sua freschezza senza avere temperatura, del suo colore senza essere visibile, della sua presenza senza occupare spazio. Bisognerebbe anche che sottratto a tutte le condizioni della vita fosse rapido come il secondo e altrettanto preciso, che nulla ritardasse il suo slancio, ostacolasse la sua grazia, appesantisse il suo sospiro, soffocasse il suo lamento. Conosciamo in questo corpo esatto, delizioso e sottile il gioco di quelle pure essenze. È l’anima rivestita di suono, o piuttosto la migrazione dell’anima attraverso i suoni, è la musica.»
Marcel Proust, Dopo l’ottava sinfonia di Beethoven (trad. Margherita Botto).