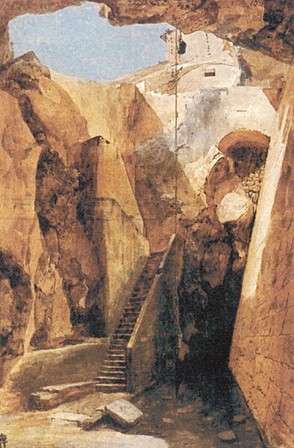È uno dei brevi saggi dello scrittore sicililiano raccolti in ‘Cruciverba’, dove utilizza la Storia “come un gigantesco cruciverba in cui orizzontali e verticali sortiscano contatti e cortocircuiti tra eventi e personaggi distantissimi. Ogni saggio è connotato da una figura, un tema o un tempo dominanti”. Lo scritto da cui è tratta la citazione è articolato attorno alla figura di don Abbondio, presentato come il prototipo di italiano, figlio di un Manzoni restituito ad una nuova valutazione critica, lontana dai pregiudizi storico-estetici di Benedetto Croce e di quelli etico-politici di Francesco De Sanctis. Lontano, cioè dalla stanca lettura proposta dalla retorica delle nostre aule scolastiche.
«Per quanto riguarda i Promessi sposi… ho avuto la fortuna (…) di averlo letto prima che me lo facessero leggere a scuola. E vi prego di credere: non è fortuna da poco, considerando le condizioni in cui la maggior parte degli italiani lo ha letto. Imperando poi, ai miei anni di scuola, la critica crociana, era anche peggio: dal punto di vista della poesia e non poesia, la lettura che Croce faceva dei Promessi sposi non differiva molto da quella che ne fece poi Moravia dal punto di vista organicità-inorganicità. Per entrambi, di fatto, I promessi sposi viene ad essere il romanzo di un intellettuale organico, organico – si capisce – al cattolicesimo. Senza poesia, per Croce; quasi di propaganda ad un cattolicesimo che porta dritto alla Democrazia Cristiana, per Moravia. (Molto più tardi, e quasi in punto di morte, Croce, come sapete, si accorse che nei Promessi sposi c’era poesia; in quanto a Moravia, credo non si convincerà mai della inorganicità di Manzoni rispetto al cattolicesimo italiano).
A scuola, il libro si riduceva a una specie di scacchiera su cui figure che non arrivavano ad essere personaggi
venivano mosse da invisibili mani dal buio alla luce, dalla sventura alla salvezza. Le mani della Grazia, le mani della Provvidenza. E con una precisa divisione di compiti: la Grazia a muovere padre Cristoforo e l’Innominato, la Provvidenza a guidare a buona sorte la «gente meccanica e di piccolo affare», ma a condizione della purezza di cuore. E benché senza le illuminazioni della Grazia non molto potesse fare la Provvidenza, a questa veniva attribuito il ruolo primario. “Protagonista del libro è la Provvidenza” assicuravano commentatori e professori.
Io invece il libro lo avevo letto, prima, con la convinzione che protagonista ne fosse don Abbondio, personaggio perfettamente refrattario alla Grazia e che della Provvidenza si considerava creditore.
(…) Il suo sistema è un sistema di servitù volontaria: non semplicemente accettato, ma scelto e perseguito da una posizione di forza, da una posizione di indipendenza, qual era quella di un prete nella Lombardia spagnola del secolo XVII. Un sistema perfetto, tetragono, inattaccabile. Tutto vi si spezza contro. L’uomo del Guicciardini, l’uomo del ‘particulare’ contro cui tuonò il De Sanctis, perviene con don Abbondio alla sua miserevole ma duratura apoteosi. Ed è dietro questa sua apoteosi, in funzione della sua apoteosi, che Manzoni delinea – accorato, ansioso, ammonitore – un disperato ritratto delle cose d’Italia: l’Italia delle grida, l’Italia dei padri provinciali e dei conte-zio, l’Italia dei Ferrer italiani dal doppio linguaggio, l’Italia della mafia, degli azzeccagarbugli, degli sbirri che portan rispetto ai prepotenti, delle coscienze che facilmente si acquietano…
Anni addietro Cesare Angelini… fu come folgorato da una domanda: perché se ne vanno? perché Renzo e Lucia, ormai che tutto si è risolto felicemente per loro, ormai che nel castello di don Rodrigo c’è un buon signore e nulla più hanno da temere, lasciano il paese che tanto amano?
Non seppe trovare risposta. E pure la risposta è semplice: se ne vanno perché hanno già pagato abbastanza, in sofferenza, in paura, a don Abbondio e al suo sistema; a don Abbondio che sta lì, nelle ultime pagine del romanzo, vivo, vegeto, su tutto e tutti vittorioso e trionfante: su Renzo e Lucia, su Perpetua e i suoi pareri, su don Rodrigo, sul cardinale arcivescovo. Il suo sistema è uscito dalla vicenda collaudato, temprato come acciaio, efficientissimo.»
Leonardo Sciascia, Goethe e Manzoni.