Un’osservazione preliminare
L’intervento della magistratura nei confronti del Comune di Milano per le note vicende legate alla gestione urbanistica ha suscitato le immediate, rituali e per lo più insopportabili dichiarazioni da parte di esponenti illustri del mondo politico.
Tutti più o meno garantisti, ma con conclusioni diverse nei confronti degli indagati, il Sindaco e l’Assessore alla “rigenerazione urbana” in prima fila:
- sono garantista quindi non si devono dimettere
- sono garantista ma si devono dimettere
- sono garantista ma resto sul generico
In questo florilegio spicca la dichiarazione della Presidente del Consiglio: “è una scelta che dovrà fare il Sindaco sulla base delle sua capacità di governare al meglio in questo scenario”. Al di là della evidente banalità della frase, non è facile capire per quale motivo la Presidente del Consiglio debba intervenire nella vicenda politico-giudiziaria di un Comune: governa il Paese o fa politica militante?
A seguire il Presidente del Senato – sempre da garantista – dice che il Sindaco si deve dimettere perché non è capace di amministrare la città. Come è noto, si tratta della seconda carica dello Stato che, per definizione, deve occuparsi della tutela delle Istituzioni del Paese certamente non delle sue vicende politiche meno che meno quelle di un Comune. Allora l’unica spiegazione possibile è che non abbia ancora capito di essere il Presidente del Senato.
Infine il Ministro della Difesa – noto esperto in materia – che tuona contro la magistratura milanese che “ha deciso di sostituirsi al legislatore nel campo dell’urbanistica”, senza dire una parola a sostegno di questa affermazione: quali leggi nazionali e/o regionali avrebbero violato i magistrati? o forse hanno violato le regole del PRG di Milano, ovvero dello strumento che regola le attività modificatorie del territorio comunale: destinazioni d’uso, indici edificatori, modalità di intervento e via dicendo? Nulla di simile è avvenuto, quindi quella del Ministro non è che una apodittica e improvvida affermazione.
Seguono molteplici dichiarazioni di politici di medio-basso rango di cui non da conto parlare.
Il nodo della questione
Detto questo, va rilevato che l’aspetto più inquietante della questione è altro ed è quasi del tutto eluso nei commenti, soprattutto da parte di coloro che dovrebbero sentirsi più direttamente coinvolti nella vicenda: gli urbanisti.
Quale che sia la loro qualifica – docenti universitari, professionisti, amministratori, funzionari – è da loro che ci saremmo aspettati una riflessione non solo sulla singola vicenda milanese, ma sul desolante stato in cui versa l’urbanistica nel nostro Paese, ridotta a mercimonio di aree, indici edificatori, standard, compensazioni.
Non è dovunque e sempre così, ma è così nella stragrande maggioranza dei casi, eppure su questo il silenzio degli urbanisti è fragoroso.
La verità è che appare del tutto rimossa la memoria storica dell’urbanistica, una nobile disciplina nata circa centosessanta anni fa per fronteggiare i guasti che andava producendo nelle città l’affluente e aggressiva società industriale e che, per definizione, era tenuta a tutelare le parti più fragili della società, quelle che avevano minore voce al momento delle decisioni sul farsi e modificarsi della città.
Una disciplina che nel nostro Paese – pur tra alti e bassi, successi e sconfitte, in anni di forti rivolgimenti economici e sociali e di due devastanti guerre mondiali – era riuscita ad assicurare un assetto dignitoso al territorio e alle sue città.
Con tempi e modalità diverse da luogo a luogo, questi assetti si sono rotti a partire dagli anni ’60 del Novecento, quando la pratica urbanistica ha cominciato a perdere il suo ruolo di strumento di equilibrio tra interessi pubblici e privati, tra volontà pressante di edificare e salvaguardia dei beni comuni.
Nel 1967 Campos Venuti pubblicava un prezioso lavoro nel quale stigmatizzava la presenza dominante nelle dinamiche urbane di un “oligopolio collusivo” composto da proprietari terrieri, imprese di costruzione e istituti finanziari che era in grado di indirizzare le scelte in materia urbanistica delle amministrazioni pubbliche. (Amministrare l’urbanistica, Einaudi, 1967)
Ed è proprio sulla scia di quel centro di potere che sono cresciuti i quartieri dei palazzinari a Roma, le espansioni nella Napoli delle “mani sulla città”, il devastante abusivismo ad Agrigento, per ricordare solo alcuni dei casi più eclatanti.
Molti anni più tardi, nel 2010, Campos Venuti rilasciava una intervista intrisa di pessimismo, nella quale confermava il netto giudizio sul ruolo negativo della rendita urbana: “la rendita fondiaria urbana rappresenta il principale fattore patologico del regime immobiliare, responsabile dei suoi effetti perversi sulla città, sul territorio, sull’ambiente e sul paesaggio”. (Città senza cultura. Intervista sull’urbanistica, Laterza, 2010)
Ma a quel tempo era già in atto una profonda modificazione del quadro generale in quanto non aveva più motivo di esistere un oligopolio collusivo visto che i tre attori componenti si trovano a convivere all’interno di uno stesso soggetto: il “promotore immobiliare”, che possiede uno stock di terreni, ha al suo interno le imprese di costruzioni e possiede in proprio le risorse finanziarie.
Per dirla in termini più prosaici, si è passati dai “Palazzinari” alle “Real Estate”
Il versante pubblico
E sul versante delle amministrazioni pubbliche – in primo luogo i Comuni – qual è la situazione?
Non c’è dubbio che vi sono fenomeni assai diffusi di corruzione e collusione che rimangono quasi sempre sconosciuti salvo per il loro immediato intorno, ma che condizionano pesantemente la pratica urbanistica.
Tuttavia, l’aspetto più inquietante è un altro e va ricercato nel rapporto di pesi tra i gestori della cosa pubblica e gli operatori immobiliari. E’ un rapporto totalmente squilibrato tra potentati finanziari e imprenditoriali da un lato e singole persone – a cominciare dai funzionari, dirigenti e assessori del settore urbanistico – dall’altro.
Dalla fase di elaborazione degli strumenti urbanistici fino alla gestione degli interventi edilizi, questo scompenso di pesi condiziona in modo decisivo le scelte e
questo è il motivo per cui i Comuni non sono più in grado di far valere il loro diritto-dovere di amministrare i territori di loro competenza.
Peraltro, va detto che l’apparato legislativo vigente non aiuta certo a risolvere questa situazione. Come è stato ripetuto mille volte, la legge urbanistica nazionale è ancor la 1150 del 1942! Gli interventi successivi hanno apportato modifiche, integrazioni e sostituzioni ma resta il fatto che una legge a misura della realtà urbana del Paese formatasi nella seconda metà del Novecento non esiste. In più le leggi urbanistiche regionali, emanate in esito alla modifica del Titolo V della Costituzione varata nel 2001, hanno creato una situazione di frammentazione delle regole in assenza di un quadro di riferimento unitario, che si è rivelata esiziale soprattutto in materia ambientale e paesaggistica.
E infine si stanno verificando fenomeni – crisi climatica, inverno demografico, transizione energetica, sperequazioni economiche – che avranno conseguenze dirette e profonde sulle città italiane. Una situazione di crisi di cui non si avverte neppure la consapevolezza.
Questa è la ragione per cui l’urbanistica va ricostruita dalle fondamenta, che è l’obiettivo che un gruppo di studiosi ha inteso perseguire di recente dando vita alla nuova rivista, “La Fenice Urbana”, che fin dal primo numero ha proposto lo slogan: “Ripensare le città, Rigenerare l’urbanistica”.
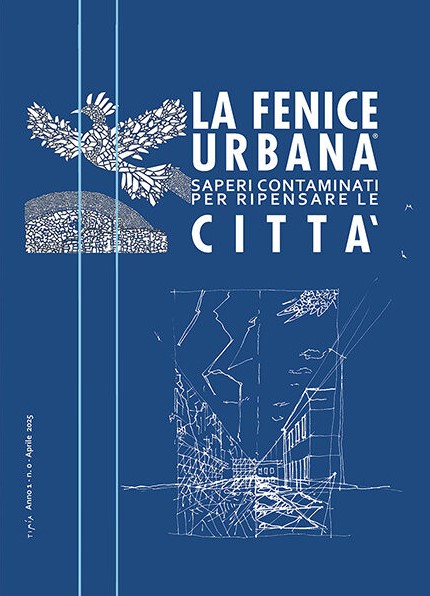
Il caso di Milano
Rispetto a questo quadro generale la vicenda milanese assume una dimensione ed un carattere del tutto particolari. Lì si è affermata negli ultimi quindici anni una deformata e deformante idea di citta – probabilmente potremmo datarne l’avvio all’indomani dell’Expo 2015 – basata su una crescita urbana sostenuta da una poderosa spinta immobiliare attorno alla quale si è formato un coagulo di archistar, urbanisti di non eccelsa fama, funzionari per varie ragioni consenzienti, imprenditori mossi da idee di grandezza oltre che dalla ricerca di profitto, amministratori incapaci quando non conniventi.
Il complesso edilizio esemplare da questo punto di vista è Porta Nuova con la sua orrenda fungaia di grattacieli – più o meno storti, più o meno boscosi – che oggi hanno la pretesa di rappresentare la città: la sua anima e la sua forma.
Un’idea di città che nessuno ha mai elaborato esplicitamente, nessuno ha mai approvato formalmente, nessuno ha mai discusso. Un’idea che il ristretto manipolo di soggetti di cui abbiamo detto ha elaborato da sè e ha forzosamente applicato a Milano dove è in atto lo scempio dell’urbanistica.


1 comment
Cose che non mi piacciono e che non dovrebbero accadere in una nazione come la nostra.
Comments are closed.