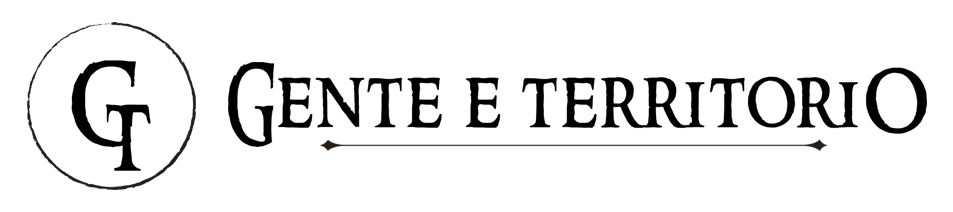Otto lunghissimi minuti. Tanto dura l’agonia di George Floyd, afroamericano quarantaseienne morto un paio di giorni fa a Minneapolis, capitale del Minnesota, uno degli stati più a nord degli USA. Non il profondo sud, dove ancora si sente qualche volta parlare del Ku Klux Klan. No, parliamo di una tranquilla comunità di circa sei milioni di abitanti nella parte storicamente più progressista del paese.
Il video è semplicemente agghiacciante nella sua laconicità. Un poliziotto ha fermato George Floyd, sospettato di aver commesso un reato, l’ha fatto scendere dall’auto e lo ha bloccato a terra con un ginocchio sul collo.
Il povero disgraziato ha implorato sempre più flebilmente: please I can’t breathe, ti prego non posso respirare. Fino a quando qualche minuto dopo non ha perso i sensi. Il poliziotto, impassibile, benché nel video si senta qualche passante che lo invita a desistere, alza il ginocchio solo quando arriva l’ambulanza. George Floyd morirà poco dopo in ospedale. Una brutale violenza, intollerabile.
La polizia all’inizio lo ha classificato come incidente medico (non so bene cosa voglia dire), ma le immagini hanno raccontato ben altro. È montata subito una violentissima protesta popolare, nonostante i quattro poliziotti siano stati licenziati e, ieri, il presunto colpevole arrestato. La città brucia e sembra una replica dei riots di Los Angeles del 1992, cinque giorni di devastazioni dopo il pestaggio da parte della polizia del nero Rodney King (anche quello filmato).
Lo sguardo freddo, distaccato e imperturbabile dell’agente di polizia mentre schiaccia il collo del malcapitato afroamericano sull’asfalto, lascia davvero annichiliti. Sembrava un cowboy, in un qualche rodeo del west, che sta semplicemente facendo il suo lavoro. Ho sempre pensato che i nazisti avessero quella espressione nei campi di sterminio e non i ridicoli sguardi psicotici cui ci hanno abituati troppi brutti film. Verrebbe di pensare a “La banalità del male” di Hannah Arendt, se non fosse ormai una definizione così abusata da perdere di forza e significato.
Certo, per noi Europei l’America è lontana, dall’altra parte della luna cantava Lucio Dalla, e facciamo bene ad indignarci, a gridare all’assassinio razzista. Un grande paese democratico, che non riesce ancora a guarire dalle sue ataviche malattie. E quindi tutti a gridare I can’t breathe, a sentirci sicuri di essere irrimediabilmente civili e immuni da queste derive abominevoli. Da noi i poliziotti devono fermare i delinquenti con tutte le attenzioni e le garanzie del caso. Ed è giusto così.
Però una riflessione ulteriore dobbiamo farla: sbaglieremmo a considerare il poliziotto americano un assassino o meglio solo un assassino. È invalso nella nostra società un principio dominante secondo il quale prima di pensare a punire i colpevoli di qualche reato, bisogna pensare al recupero, al contesto di degrado in cui è cresciuto il criminale. Segno di raffinatissimo sviluppo sociale.
Ecco, se oltre l’orrore e l’indignazione, cercassimo di indagare il meccanismo perverso che porta ad un gesto così efferato, certo frutto di scelte individuali, capiremmo che forse è anche conseguenza di un modello politico e sociale malato, dove il nero, il povero, il diverso fa paura e va eliminato. Se provassimo a considerare anche il poliziotto di Minneapolis un individuo semplicemente lasciato da solo e stritolato da un congegno infernale, magari riusciremmo a capire come invertire la rotta. Mi pare lo avesse già scritto Pasolini quasi cinquant’anni fa.