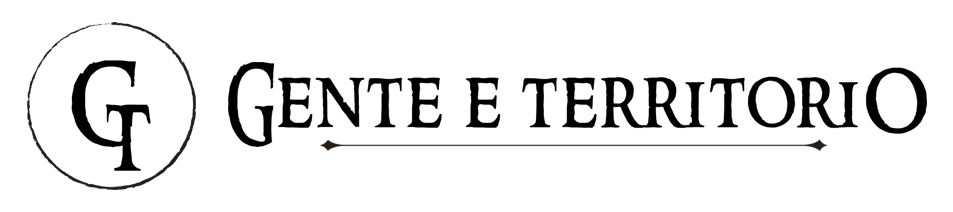Un breve prologo
La “restanza” è un termine che non esiste nei dizionari della lingua italiana – con l’eccezione del Vocabolario Treccani on-line che lo inserisce nei Neologismi 2017 – ma per fortuna ne parla nel suo sito Internet l’Accademia della Crusca e, ancora più diffusamente, Raffaella Setti nell’Italiano digitale – La rivista della Crusca in Rete (XXIV, 2023/1), riportando una definizione che sembra ormai largamente condivisa: “atteggiamento di chi, nonostante le difficoltà e sulla spinta del desiderio, resta nella propria terra d’origine, con intenti propositivi e iniziative di rinnovamento”.
Con questo significato, ricorda sempre la Setti, il termine è stato usato per la prima volta dall’antropologo Vito Teti nel suo libro “Pietre di pane: Un’antropologia del restare” (Quodlibet, 2011), dove un paragrafo è titolato, appunto, “La Restanza”.
Più di recente Vito Teti – un illustre studioso, già ordinario di Antropologia culturale nell’Università della Calabria – lo ha voluto come titolo di un altro suo libro: La restanza (Einaudi, 2022).
E’ lì che ho incontrato per la prima volta quel termine che per me era del tutto sconosciuto, ma mi sono subito detto: se per chi parte parliamo di “partenza”, per quale motivo per chi resta non dovremmo parlare di “restanza”? E forse, per tutto quello che ruota attorno alla lunga e aperta vicenda dei paesi abbandonati, dovremmo parlare anche di “tornanza”, un altro termine che non compare nei dizionari della lingua italiana.
De te fabula narratur
E’ su questa vicenda che vorrei fare alcune considerazioni a partire dalla lettura del libro di Teti nel quale convivono due voci narranti diverse ma inseparabili tra loro.
Una è quella dello studioso con le sue complesse, raffinate e sofferte riflessioni sul senso dell’inscindibile binomio “partire-restare”, di cui credo si debba cogliere il richiamo alla comunità degli antropologi ad “interagire, anche in maniera dissidente , oppositiva, con la politica, con le altre discipline (…) per mostrarsi all’altezza dei tempi, per individuare e indicare altre strade, altre memorie, altri legami e patti osmotici tra uomo e natura” ovvero, in altri termini, a praticare un’antropologia “non più percepita come la disciplina che si occupa di modi estinti o in estinzione (…) ma come pratica sociale capace di accogliere quel che resta, di sentire, aggiornare e comprendere per partecipare alla nascita di mondi nuovi”.
L’altra voce è quella della personale esperienza di chi, come l’Autore, quella condizione la vive da sempre e la racconta con fierezza, commozione e angoscia mescolate tra loro: “Abito (…) nella casa in cui sono nato, dormo nella stanza in cui mia madre mi mise alla luce (…) Il paese che ho visto pieno adesso è vuoto. Le case e le strade sono vuote. Assisto alla morte del paese. E’ struggente. Da bambino aspettavo il ritorno di mio padre, adesso assisto alla partenza dei miei figli”.
A me sembra che ascoltando questa duplice narrazione si riesca a comprendere quello che Teti dice fin dalle prime pagine del libro: “l’aspetto che più mi sta a cuore: riabitare i paesi interni, riabitare la montagna, guardare al centro della prospettiva inedita ed umanissima della periferia, mi sembra possa essere una delle vie di salvezza per l’intero sistema Paese”.
Un altro punto di vista
Partendo da qui provo a proporre un altro punto di vista che non è un punto di vista “difforme” da quello di Vito Teti, ma un punto di vista “aggiuntivo” rispetto a quello da lui espresso, perché traguarda la questione con altri occhi.
Devo dire subito che non sono gli occhi della mia vicenda personale, perché se così fosse dovrei parlare da “errante”, visto che ad oggi conto quattordici case in cui ho abitato, in cinque diversi luoghi tra paesi e città.
Di ognuna di loro ho memoria visiva e un inevitabile accumulo di ricordi, ma solo per una ho avuto, e avverto ancora, la sofferta sensazione del distacco e dello strappo dal luogo di vita nel quale sarei voluto rimanere. Peraltro oggi quella casa – che stava dentro una modesta palazzina a due piani di quattro appartamenti situata in piena campagna – non esiste più e al suo posto passa una grande strada. Anche dopo decenni, non trovarla dove l’avevo lasciata mi ha dato una fitta sensazione di straniamento.
Ma per tutte le altre volte, da tutte le altre case, sono partito senza particolari traumi, senza mai tornare e senza lasciare alcuna comunità che, in realtà, non ho mai avuto.
Dunque ne parlo da un altro punto di vista, quello del mestiere che faccio da oltre quaranta anni – l’urbanista – un mestiere che ha a che fare, per definizione, con i luoghi in cui vivono le persone, luoghi che è tenuto a studiare attentamente per capirne sia la fisicità (la città di pietra) sia l’anima che esprime la comunità che lì vive (la città dei cittadini). Poi, anche una volta che ha capito, l’urbanista non può fermarsi perché il suo compito va oltre: è quello di immaginare un futuro per quei luoghi e di elaborare i piani e i progetti capaci di inverare quel futuro. Questo è il punto di vista “altro” con cui cerco di parlare del nostro caso di specie.
La realtà dei paesi che abbiamo di fronte è quella che Teti e gli altri studiosi della “partenza-restanza” hanno analizzato in profondità e illustrato nei loro scritti, e il quadro che emerge è tale che il destino di questi centri appare irreversibilmente segnato se qualcosa non interviene a modificarne la traiettoria di abbandono e di decadenza.
Ebbene, per usare un termine oggi molto usato e poco capito, questo è possibile solamente “rigenerandoli”, vale a dire ponendo in essere un insieme di azioni, progetti e interventi capaci di costruire per quei centri un genere diverso, per conferire loro “un complesso di caratteri essenziali e distintivi” (Devoto-Oli, 1987) che risponda alle esigenze, ai desideri, alle aspettative di chi in quei paesi è restato, di chi vorrebbe tornare a viverli, di chi vorrebbe frequentarli in una dimensione del tutto nuova: temporanea, ludica, delle radici, del migrante.
Un possibile percorso
Dare vita a questo processo rigenerativo è un compito estremamente difficile da affrontare, ma certamente ineludibile se non si vuole accettarne la perdita definitiva. E allora? E allora l’urbanista, che è stato formato per questo compito, deve mettere in campo i suoi strumenti per indicare soluzioni idonee.
A questo proposito va subito detto che nel nostro Paese l’urbanistica ha da tempo dimenticato questo compito nei riguardi dei paesi di cui parliamo, per calarsi in una dimensione urbanocentrica assoggettata al connubio di interessi della rendita fondiaria e della speculazione edilizia. Non che questo abbandono (tradimento?) del suo compito originario – quello maturato a partire dalla seconda metà dell’Ottocento – sia la causa primaria del fenomeno di spopolamento di quei paesi, ma certamente da quel versante è venuto nulla che potesse contrastarne gli aspetti più degenerativi.
Ciò significa che se voglio dare un senso ad un punto di vista “altro” devo assumere che questo punto di vista non appartiene al modo in cui oggi abitualmente si fa urbanistica. Al contrario presuppone un deciso cambiamento del suo orizzonte teorico e pratico se si vuole che, in analogia con quanto Teti richiede per l’antropologia, l’urbanistica si costituisca come pratica sociale capace di incidere nella realtà dei paesi dell’abbandono, indicando per quei luoghi un percorso di rigenerazione.
Come ho detto si tratta di un compito estremamente difficile da affrontare, di cui mi sento solo di elencare alcune questioni fondamentali dalle quali credo si debba partire o, forse meglio, senza le quali credo non sia possibile mettere mano ad un problema della portata di quello in esame.
La prima questione è: qual è la dimensione del fenomeno di cui parliamo?
Usando l’indicatore della popolazione sappiamo che nel nostro Paese vi sono circa 5.500 centri con meno di 5.000 abitanti. Di questi circa 4.000 sono ubicati in aree interne, quelle segnate da difficoltà nei collegamenti e da mancanza di scuole, presìdi sanitari, uffici postali, esercizi commerciali, reti telematiche, biblioteche, impianti sportivi, spazi ricreativi, ovvero di tutto ciò che rende accettabile abitare in un luogo.
In termini di superficie questi paesi coprono quasi il 60% del territorio nazionale e la loro popolazione ammonta a circa 13.0 milioni, quasi il 23.0% del totale.
E’ questo l’universo insediativo a cui dobbiamo fare riferimento nell’elaborare le strategie di intervento.
La seconda questione è: che fare per restituire questi paesi a nuova vita?
Per grandi linee la prospettiva verso cui muovere è quella ripetutamente delineata nel suo lavoro da Teti e dagli altri studiosi da lui richiamati: l’avvio di una agricoltura di prossimità, la cura e il presidio dell’ambiente naturale, la valorizzazione dei paesaggi, la riqualificazione del patrimonio architettonico e insediativo, la riscoperta delle culture locali, l’accoglienza di genti nuove e altro ancora.
Ma ognuno di questi aspetti va approfondito nei contenuti e posto in relazione ai diversi contesti, studiandone attentamente le peculiarità e le vicende che li hanno caratterizzati, perché niente è peggio delle generalizzazioni e delle soluzioni buone ovunque. E’ di evidenza palmare che le Langhe sono altra cosa dall’Aspromonte e che l’esodo volontario del migrante è altra condizione dal trasferimento coatto causato da eventi disastrosi: terremoti, frane, alluvioni.
Dunque è necessario uno studio delle aree interne esteso all’intero territorio nazionale e, al contempo, capace di cogliere la grana fine delle situazioni locali.
La terza questione è: chi deve avviare un simile percorso?
Se è vero, come ho ricordato, che oltre la metà del territorio nazionale versa in uno stato di abbandono e che quasi una persona su quattro vive in condizioni di marginalità, è un imperativo categorico che sia lo Stato con le sue istituzioni parlamentari e governative ad avviare quel percorso, anche perché deve inquadrare il problema delle aree interne e dei centri abbandonati alla luce dei più generali problemi causati da alcuni macrofenomeni da tempo in atto: le conseguenze dei cambiamenti climatici, il deterioramento dell’ambiente naturale, la dura lezione della pandemia in tema di salute, l’inverno demografico, le epocali migrazioni di genti verso il nostro Paese.
Sono problemi che richiedono uno sguardo d’insieme, una strategia complessiva, un impegno di ingenti risorse umane e finanziarie e, prima di ogni altra cosa, un radicale cambiamento di prospettiva che parta dal chiudere la fase espansiva e urbanocentrica che ha caratterizzato il nostro Paese dagli anni Cinquanta del Novecento, e apra una fase di “rigenerazione” che abbia tra i riferimenti centrali la messa in gioco delle aree interne e dei paesi abbandonati.
E’ tempo che lo Stato con le sue istituzioni cominci ad occuparsi seriamente di simili questioni, perché hanno a che fare con l’assetto e la qualità di vita dell’intero sistema Paese.